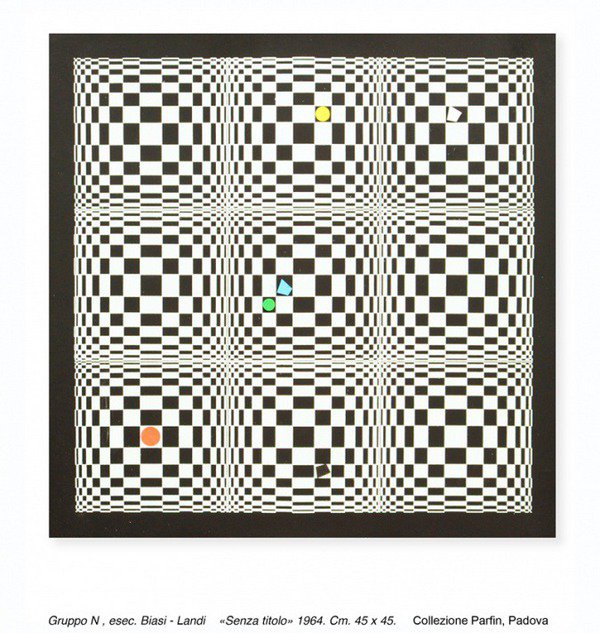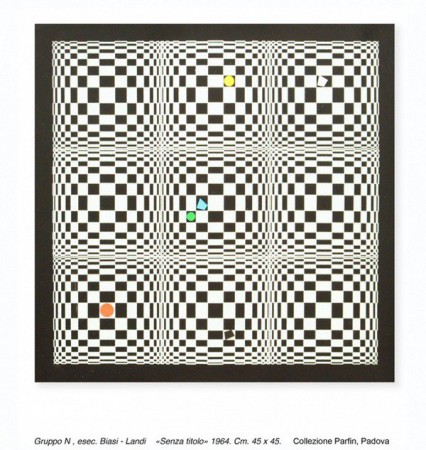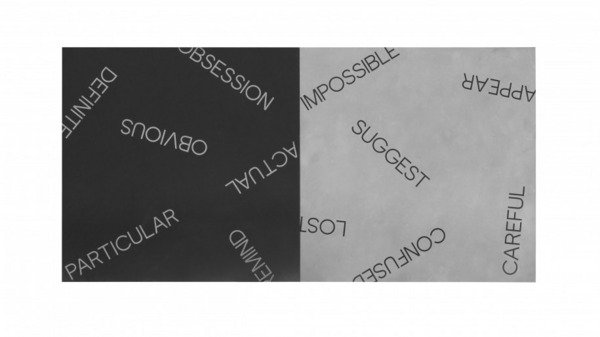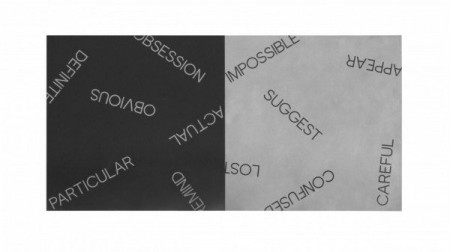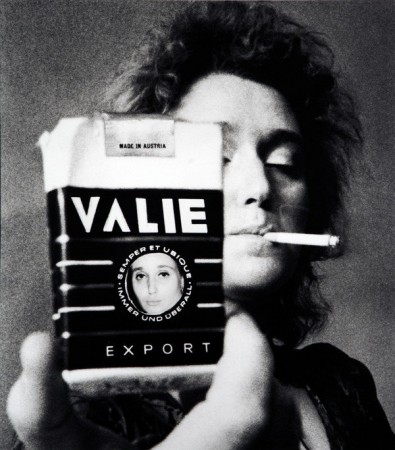Per lei, Marina, tutto iniziò chiacchierando con un pastore sardo il quale, ogni volta che prendeva parola, chiudeva gli occhi, perchè a suo dire mentre parlava non aveva bisogno di guardare. Per me invece è iniziato tutto con un messaggio su WhatsUpp: “La mia amica non viene, vieni tu?”. Così mi sono ritrovata al Pac, di nuovo, ma questa volta per regalare due ore del mio tempo alla nonna della performance art Marina Abramovic. Forse dopo il mio ultimo articolo qualcuno lassù ha pensato che bisognava darmi una seconda chance.
E così ho firmato il contratto, la liberatoria per le riprese, ho promesso di non avere attacchi di panico e sfilato di fronte al pubblico fino ad arrivare nell’ultima sala, lì dove il metodo ha inizio. Dove Marina ti chiede di indossare il camice bianco, accomodarti sulla sdraio bianca e chiudere gli occhi come faceva il pastore sardo. È facile darle fiducia, perchè ha il tono di chi sa quello che fa e te lo racconta come una nonna spiegherebbe la torta di mele alla nipote, nulla di più semplice. Ora io vorrei con le parole farvi incarnare in me stessa, così da provare a capire le stesse cose che mi sono passate nelle mente per quelle due ore di pausa dalla realtà, ma non è possibile. E poi, molto probabilmente, vi interesserebbero poco perché è davvero un’esperienza personale: io, spettatore, mi incarno nel corpo dell’artista, entro nella sua arte e la rendo possibile.